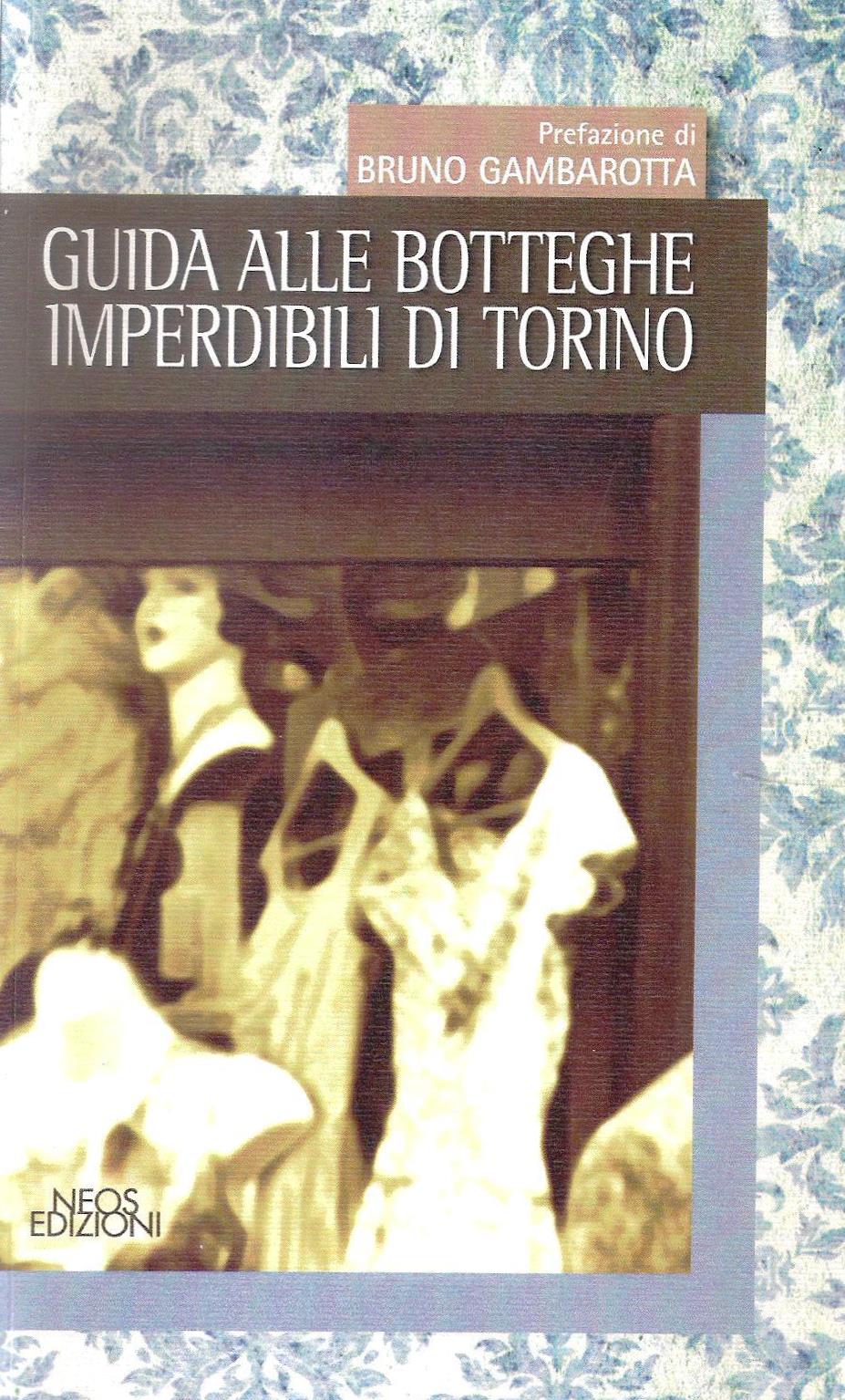A.A.V.V. GUIDA ALLE BOTTEGHE IMPERDIBILI DI TORINO, NEOS EDIZIONI, Rivoli (TO), Gennaio 2014, pp. 96, 10€
Recensioni a cura di Daniela Aragno, Rudy Bara, Claudio Bellavita, Maddalena Merlino, Claudio Paletto, Laura Remondino, Giuliana Ricagni, Mino Rosso, Caterina Schiavon, Ferruccio Sossich, Manuela Tartari.
Prefazione di Bruno Gambarotta.
Introduzione di Mino Rosso
Prefazione
PREFAZIONE
Il proposito di tessere l’elogio sincero, e motivato con solidi argomenti, delle botteghe, incontra all’inizio del suo percorso un ostacolo che, pur essendo un logoro luogo comune, è saldamente radicato. Si tratta dell’alone negativo che circonda le parole derivate dal lemma “bottega”. Quante volte abbiamo ascoltato o letto l’accusa fatta a un uomo politico che avrebbe agito “ispirato da interessi di bottega” (sottinteso, anziché da alti ideali). Gabriele d’Annunzio, quando esortava gli italiani a entrare nel mattatoio della Prima Guerra Mondiale, tuonava contro lo “spirito bottegaio” dei neutralisti che poi erano la maggioranza. Il Vate ometteva di specificare che anche gli industriali che sovvenzionavano gli interventisti lo facevano per la loro “bottega” dove si fabbricavano armi. Su questa strada Benito Mussolini si dimostrò un ottimo allievo: per fustigare i restii a seguirlo nell’avventura del suo impero di cartone, a saltare nel cerchio di fuoco, al termine “bottegai” accoppiava quello di “pantofolai”.
Nella Francia del dopoguerra, nella lotta politica l’accusa più ricorrente che rimpallava fra gli avversari era quella di rappresentare la “Francia bottegaia”. Sul vocabolario Sabatini-Coletti, alla voce “bottegaio” troviamo la definizione: “persona che ragiona solo in termini di piccolo profitto, gretto, meschino, venale”. Quest’uso metaforico di bottega prosegue. Il 21 dicembre del 2013 Massimo Gramellini dedica la sua rubrica Buongiorno alle oscillazioni della giustizia sportiva e scrive: “Se si deve rispettare una norma di civiltà il regolamento viene adattato alle esigenze di bottega”. L’esempio viene dall’alto: ne I Promessi Sposi la parola bottega ritorna 22 volte e 9 il plurale botteghe. Tutte usate in senso proprio, una sola in senso figurato. Siamo nel capitolo XXXI, si parla delle peste a Milano nel 1630 e di quei medici odiati dal volgo perché cercano di gettare l’allarme sui pericoli del contagio: “I più discreti li tacciavano di credulità e d’ostinazione: per tutti gli altri era manifesta impostura, cabala, ordita per far bottega sul pubblico spavento”. E pensare che fu l’esigenza di mercanti e di bottegai di poter agire in una zona franca dalle mille gabelle feudali a far nascere i Comuni che portarono l’Italia fuori dal Medioevo. E pensare che sono state le botteghe i primi luoghi dove noi bambini abbiamo potuto avventurarci fuori dal nido. Con mille raccomandazioni e tenendo stretta fra le minuscole dita la lista delle cose da comprare per consegnarla al negoziante poiché non sapevamo ancora leggere. Eravamo più piccoli del bancone, gli adulti ci passavano davanti finché una signora caritatevole non faceva notare la nostra presenza alla padrona o alla commessa. Oltre alla lista della spesa, molti di noi, prima di essere mandati in missione, dovevano dar prova di avere imparato a memoria la frase da dire dopo aver messo al sicuro la borsa con gli acquisti: “Mia mamma ha detto di segnare che passa poi lei a pagare”. Sottinteso: “a fine mese, quando mio papà porterà a casa il mensile”. Le mamme confidavano, a ragione, nell’umanità di bottegai che non avrebbero avuto cuore di umiliare un bambino facendosi restituire gli acquisti appena fatti. Almeno una volta nel corso della nostra infanzia arrivava l’incarico di andare nel negozio a chiedere: “Mia mamma ha detto di farmi dare un etto di murupist e, se non ce l’ha, che me lo pesti”. Quella commissione di un etto di muso pestato, accolta dalle risate dei clienti presenti in negozio, non l’avremmo più dimenticata. Le botteghe sono l’archivio principe delle nostre memorie. Lo sanno gli scrittori, storiografi della vita privata. In una sterminata moltitudine di romanzi la bottega è l’antro delle meraviglie e il ricettacolo dei tesori nascosti. Il protagonista si affaccia sulla soglia della bottega, collocata preferibilmente in un vicolo, per entrare spinge la porta cigolante che si apre facendo tintinnare un campanello. Dal fondo semibuio si affaccia un padrone o un commesso, sempre in là con gli anni; sarà lui a procurare il gioiello, il manoscritto, il libro antico, la mappa, il pugnale, oggetti dei desideri dell’eroe, strumenti per arrivare alla scoperta del tesoro.
Può perfino trattarsi di un falco maltese, una statuetta d’oro ricoperta di pietre preziose laccata di nero per distrarre l’attenzione dei ladri, dono dei Cavalieri di Malta all’imperatore Carlo V: “Per settant’anni, quell’oggetto stupendo rotolò, è il caso di dire, per tutti i rigagnoli di Parigi… fino al 1911. Fu allora infatti che un mercante greco, un certo Charilaos Konstantinides, lo trovò in una misera botteguccia. Non ci mise molto a capire di che si trattava e lo acquistò. Nessuno strato di vernice o smalto o quel che era poteva nascondere ai suoi occhi, e al suo naso, il valore vero dell’oggetto”. (Dashiell Hammet, Il falco maltese) Per interessare i narratori le botteghe devono essere antiche, passate tra le mani di almeno tre generazioni di proprietari, l’esatto contrario dei temporary shop che vanno ora di moda, aperti e richiusi nell’arco di poche settimane, in modo che il cliente, quando torna a protestare, si trovi di fronte a un vuoto contenitore. Le botteghe amate dai nostri narratori, e di conseguenza da noi lettori, non conoscono l’onta delle rese, le merci si sono accumulate stagione dopo stagione per cui le visitiamo sicuri di trovare manufatti la cui produzione si è conclusa mezzo secolo fa. Anche la letteratura fa grande uso di botteghe.
Anche se negli elenchi dei romanzi che hanno superato la prova del tempo ne troviamo solo due con la parola bottega nel titolo. Il primo è La bottega dell’antiquario di Charles Dickens. La descrizione di questa bottega londinese, fin dal primo capitolo, non ci sorprende: “Il locale… era uno di quei ricettacoli di anticaglie e di curiosità, che sembrano annidarsi in strani angoli di questa città, nascondendo agli occhi del pubblico, per gelosia e per diffidenza, i loro tesori ammuffiti. Qua e là vi erano giachi di maglia, ritti come spettri rivestiti di armature; bizzarre sculture portate via da chiostri conventuali; armi arrugginite di vario genere; figure contorte di porcellana, di legno, di ferro e di avorio; arazzi e strani mobili che sembravano disegnati in sogno. L’aria sconvolta dell’ometto si addiceva mirabilmente al luogo. Forse si era aggirato fra chiese antiche, tombe e case abbandonate, e aveva raccolto con le proprie mani tutte quelle spoglie. Non vi era nulla in tutta quella collezione che non fosse in armonia con lui: nulla che sembrasse più vecchio o più disfatto di lui”.
Il secondo titolo è un capolavoro del ‘900, conosciuto meno di quanto meriterebbero la fantasia surreale e la prosa smagliante che lo caratterizzano: Le botteghe color cannella dello scrittore polacco Bruno Schulz, ambientato nella città dove nel 1892 nacque l’autore, Drohobycz, allora nella Galizia austro ungarica. In quel paese occupata dai tedeschi l’ebreo Schultz fu ucciso il 12 novembre 1942 da un SS. Suo padre Jakub, protagonista dei racconti inanellati nel libro, aveva un negozio di tessuti e di pannilani. Ma “le botteghe color cannella” del titolo si trovano in un’altra parte della cittadina. “Quei negozi così nobili, ancora aperti a notte inoltrata, erano sempre stati per me oggetto di fervidi sogni. Fiocamente illuminati, scuri e solenni, i loro interni odoravano intensamente di vernici, lacca, incenso, aromi di terre lontane e merci rare. Ci si potevano trovare bengala, scatole magiche, francobolli di paesi da tempo scomparsi, decalcomanie cinesi, indaco, colofonie di Malabar, uova di insetti esotici, di pappagallo, di tucano, salamandre vive e basilischi, radici di mandragola, giocattoli meccanici di Norimberga, homunculi in vaso, microscopi e binocoli, vecchi in-folio pieni di incisioni straordinarie e di storie sorprendenti.
Ricordo quei vecchi, dignitosi venditori che servivano i clienti a occhi bassi, in un silenzio discreto, ed erano pieni di perspicacia e comprensione per i loro più segreti desideri. Ma soprattutto c’era là una libreria in cui una volta avevo dato una scorsa a certe edizioni rare e proibite, pubblicazioni di un qualche club clandestino, che mi avevano svelato misteri angosciosi ed eccitanti”.
Scrive Angelo Maria Ripellino nell’introduzione: “Bruno Schultz tradusse nel 1936 in polacco Il Processo di Kafka.
Il rapporto della sua arte con quella kafkiana è fortissimo”. Anche il padre di Franz Kafka aveva una bottega di stoffe, a Praga. Il figlio fa rivivere i suoi ricordi infantili nella sconvolgente Lettera al padre: “Finché la bottega fu sulla strada, non poteva che piacermi; era così animata, piena di lumi la sera, si vedevano e udivano tante cose; capitava di dare un aiuto, di farsi notare, e in primo luogo si ammiravano le Tue grandi capacità commerciali: come sapevi vendere, trattare con il pubblico, scherzare, com’eri instancabile e pronto a decidere nei casi dubbi, e così via. Era anche bello vederTi fare un pacco o aprire una cassa, e certo per noi bambini non fu un cattivo insegnamento”.
Sostiamo ancora nel capitolo dei grandi scrittori di origine ebrea. Anche gli antenati di Primo Levi erano negozianti di stoffe: a loro è dedicato il primo capitolo de “Il sistema periodico”, a proposito dell’Argon, un gas nobile. Rievoca il gergo scaturito dalla mescolanza fra il dialetto piemontese “scabro, sobrio e laconico e l’incastro ebraico, carpito alla remota lingua dei padri”. Un suo uso “era in bottega, fra il padrone e i commessi e contro gli avventori: nel Piemonte del secolo scorso il commercio delle stoffe era sovente in mani ebraiche, e ne è nato un sotto gergo specialistico che, trasmesso dai commessi divenuti a loro volta padroni, e non necessariamente ebrei, si è diffuso a molte botteghe del ramo e vive tuttora, parlato da gente che rimane assai stupita quando viene casualmente a sapere che sono parole ebraiche. Qualcuno, ad esempio, impiega ancora l’espressione “’na vesta akinìm” per indicare “un vestito a puntini”: ora i “kinìm” sono i pidocchi, la terza delle dieci piaghe d’Egitto, enumerate e cantate nel rituale della Pasqua ebraica”.
Ritorniamo nell’Ottocento e da Torino andiamo a Parigi dove Emile Zola intitola l’undicesimo romanzo del ciclo dedicato ai Rougon-Macquart all’insegna di una bottega: Al Paradiso delle signore del 1883. Il grande maestro del realismo contrappone le due tipologie della bottega, la lussuosa e la misera. La ventunenne Dionisia sbarca all’alba alla stazione di Saint-Lazare con i due fratelli minori. Sono rimasti orfani di entrambi e genitori e arrivano a Parigi per mettersi sotto la protezione dello zio Baudu.
Recandosi a piedi all’indirizzo dello zio si imbattono in un grande negozio di “novità” la cui insegna recita “Al Paradiso delle signore”. Dionisia che a Valognes lavorava come commessa di un negozio di confezioni per signora si blocca incantata davanti a tutte le numerose vetrine, una più splendida dell’altra. Zola, fedele al suo metodo, le descrive tutte con estrema accuratezza. Dalla pagina dedicata alla vetrina dei vestiti citiamo un breve frammento: “Nel mezzo, non plus ultra delle meraviglie, un mantello di velluto con guarnizioni di volpe argentata; ai lati, qui una cappa di seta foderata di vaio, là un cappotto di panno orlato di penne di gallo. (…) Ce n’era per tutti i capricci, dal mantello da passeggio a ventinove franchi a quello di velluto da milleottocento. Il petto colmo dei manichini di legno gonfiava la sottigliezza della vita; invece della testa c’era un largo cartellino, col relativo prezzo, appuntato con uno spillo nella felpa rossa del collo; e gli specchi, dai due lati della vetrina, con un effetto studiato apposta, li riflettevano e li moltiplicavano senza fine, popolando la strada di tante belle donne in vendita che avevano segnato con vistosi numeri il prezzo al posto del capo”. Non potrebbe esserci un maggiore contrasto con la bottega dello zio Baudu che i tre fratelli, fatti pochi passi, incontrano in via della Michodière: “Videro un’insegna verde con le lettere gialle scolorite dalla pioggia: Al vecchio Elbeuf, stoffe e flanelle, Baudu, successore di Hauchecorne (…) Ciò che fece più effetto a Dionisia fu la bottega del pianterreno, come schiacciata dal soffitto basso, e con di sopra un mezzanino dove le roste a mezzaluna l’assomigliavano a una prigione. In una inquadratura di legno, dello stesso color dell’insegna, ossia un verde-bottiglia cui il tempo aveva dato sbavature di ocra e di bitume, si aprivano a destra e a sinistra due vetrine profonde, nere, polverose, nelle quali si discernevano vagamente pezze di stoffa ammucchiate a casaccio. La porta spalancata pareva avviare alle tenebre umide di una cantina”.
Fra gli scrittori italiani dell’Ottocento c’è chi promuove al ruolo di protagonisti una coppia di bottegai allo scopo di far divertire il lettore. E’ il caso di Achille Giovanni Cagna con il suo Alpinisti ciabattoni, del 1888, ripubblicato da Piero Gobetti Editore nel 1925 e infine rilanciato da Italo Calvino nel 1972 nella collana di Einaudi Cento pagine.
I coniugi Gaudenzio e Martina Gibella, dopo trent’anni di ininterrotto servizio presso la loro bottega di Sannazzaro, si concedono una vacanza sul lago d’Orta. Inesperti delle cose del mondo, incappano in una serie di comiche disavventure che culminano nell’estrazione di un molare sano al posto di quello che procura un dolore insopportabile alla signora Martina. Non c’è da stupirsi perciò se a più riprese i coniugi Gibella rimpiangono il loro nido: “Gudenzio sospirava ricordando come in sogno il suo bel seggiolone lasciato laggiù nel suo botteguccio tiepido, riparato, olente dei profumi di coloniali; il retrobottega ov’era la cucina, l’ampio fornellone nero di fuliggine, rallegrato dalla fiamma che lambiva la marmitta nera, grassa, piena di brodo gorgogliante e bollente.
Ah Dio, che letizia sorbire una buona tazza di brodo caldo in quel cantuccio tiepido!” E altrove, quando un malanno lo tiene sveglio nel letto dell’albergo: “Quel povero cervello di droghiere, che non aveva mai pensato ad altro che al suo botteghino, e fuori dello zuccaro, del caffè, del suo libro di conti, non aveva mai lanciato né un dubbio, né un interrogativo al di là delle quotidiane consuetudini, adesso un po’ per il rovello della febbre, un po’ per la malinconia, naufragava in un pelago di tetraggini opprimenti. Oh perché aveva lasciato la sua casetta così tranquilla per imbarcarsi in tante avventure!”
Fra i molti autori italiani della seconda metà del Novecento che hanno inserito le botteghe nelle loro narrazioni citiamo un solo nome per non dilatare ulteriormente un’introduzione che ha già preso troppo spazio. Nel romanzo “Tra donne sole” Cesare Pavese fa parlare in prima persona la protagonista Clelia che ritorna a Torino da Roma dove ha fatto carriera nel mondo della moda, con un incipit stupendo: “Arrivai a Torino sotto l’ultima neve di gennaio, come succede ai saltimbanchi e ai venditori di torrone”. Siamo nei primi anni del dopoguerra e Clelia ha l’incarico dall’azienda per cui lavora di sovrintendere ai lavori per l’apertura di un nuovo atelier in via Po e non resiste alla tentazione di tornare a vedere, senza farsi riconoscere, il laboratorio in cui aveva iniziato a lavorare da bambina e dal quale era partita diciassette anni prima per tentare l’avventura a Roma.
“Lasciando il parrucchiere non pensavo che al vecchio cortile, e rientrai in albergo, deposi la pelliccia, mi misi il soprabito. Bisognava che tornassi in quella via della Basilica, e magari qualcuno poteva riconoscermi; non volevo avere l’aria superba.
C’ero andata; avevo prima girato i paraggi. Conoscevo le case, conoscevo i negozi. Fingevo di fermarmi a guardare le vetrine, ma in realtà esitavo, mi pareva impossibile d’essere stata bambina su quegli angoli e insieme provavo come la paura di non essere più io. Il quartiere era molto più sporco di come lo ricordavo. Sotto il portico della piazzetta vidi la bottega della vecchia erborista; c’era adesso un ometto magro, ma i sacchetti di seme e i mazzi d’erbe eran gli stessi. Di lì, nei pomeriggi d’estate veniva un profumo intenso, di campagna e di droghe. (…)
Ero arrivata in via della Basilica e non ebbi il coraggio.
Passai davanti a quel cortile, levai gli occhi, intravidi la volta bassa e i balconi. Ero già in via Milano. Impossibile tornare”.
Nelle nostre città e in particolare a Torino, le botteghe sono sempre state un motore di progresso e di modernità. L’Archivio Storico della Città di Torino ha realizzato nel 2003 la mostra “Premiata ditta”. Scrive sul catalogo Luciana Manzo, curatrice della mostra: “Nel corso dell’Ottocento il commercio al minuto occupa spazi sempre più rilevanti della città trasformando radicalmente l’ambiente urbano. Per secoli esso era stato considerato una fonte di disturbo e di disordine. Le vie in cui si concentravano le botteghe erano rumorose e caotiche, ingombre di merci esposte sui banchi posti all’aperto.
L’arredo era essenziale, le insegne che riproducevano sommariamente l’immagine dell’oggetto venduto erano realizzate da mastri da bosco, fabbri, decoratori secondo modelli ripetitivi e impiegando materiali poco pregiati, funzionali ma molto lontani da preoccupazioni di tipo estetico. (…) Il commercio, da ingombrante necessità, si trasforma in fonte di lucro per i proprietari di immobili:
poiché destinare il piano terreno a botteghe garantisce una rendita sicura, fin dalla progettazione degli edifici spesso si provvede a disegnare decorazioni per lo zoccolo commerciale che richiamano le cornici degli androni e dei passi carrai”. Sempre su questo prezioso catalogo troviamo la citazione dalle memorie di Vittorio Bersezio (I miei tempi) come testimonianza sulla prima metà dell’Ottocento: “le botteghe avevano una modesta semplicità… non avevano né vetrine, né lucide insegne, né merci in mostra, né splendore di specchi, né indorature, né eleganze di mobili, né sfolgorio di illuminazione… Facevano eccezione a quella modestia i caffè e le confetterie, che presentavano all’avventore volte riccamente dipinte, pareti artisticamente stuccate, ampi specchi a cornici dorate, sofà e seggiole coperti di velluto”.
Devono trascorrere pochi decenni perché l’eccellenza delle botteghe di Torino diventi un primato che nessuno osa mettere in discussione. Scrive Pietro Baricco, nel suo Torino descritta, pubblicato da Paravia nel 1869: “Molti ed eleganti i negozi di stoffe sia per vestire le persone sia per addobbare le abitazioni: i magazzini detti di moda e di novità, quelli di abiti fatti, di sete e lane per ricami, e di tele per ogni genere di biancherie sono frequenti, e a gran dovizia forniti. Splendide oltremodo sono le botteghe degli orefici, dei venditori di mobili e dei chincaglieri, non solo per la copia delle merci esposte alla vendita, ma eziandio per la ricchezza delle bacheche e la forma elegante delle mostre. Havvene alcune di legni preziosi e di marmi finissimi, e così vagamente adorne di ori, di bronzi e di cristalli, che sono mirabili a vedersi, specialmente la sera quando riflettono la viva luce del gaz”. Per quanto riguarda le insegne, l’ansia di modernità incalza, al punto che Alberto Viriglio, nel suo Torino e i torinesi, del 1898, si dimostra già nostalgico del passato: “Alla maestà delle insegne del passato onuste d’ori, di intagli e di bestioni araldici caccianti un palmo di lingua, si è sostituita la democrazia livellatrice del ferro smaltato. (…) Più non vedremo gli angioloni di legno verniciato appesi per le spalle e portanti mazzi di candele, pani di zucchero, matasse di lasagne. (…) Tramontano le pelli conciate, gli intrecci di chiavi e campanelli a molla, i bioccoli di lana vergine. (…) Ora si dipinge tutto quanto si intagliava. Si tende a una uniformità di concetto desolante”.
Come sempre succede le parole sono rivelatrici dei sentimenti e delle passioni di chi le usa. A testimoniare l’amore dei torinesi per le botteghe c’è il termine dialettale per vetrina: Giojera, che richiama l’idea di esibizione di cose preziose. Leggiamo la definizione di giojera sull’insuperato Gran Dizionario Piemontese-Italiano di Vittorio di Sant’Albino del 1859: “Vetrina. Scancia o cassetta a vetri a mo’ di scannello, ove i bottegaj tengono in pubblica mostra gioje, minuterie d’oro e d’argento, libri, drappi, e simili”.
Ecco la nostra giojera sulla quale, per una volta, mettiamo in bella mostra le vere, autentiche, magnifiche botteghe di Torino. Con l’augurio che durino ancora a lungo.
Bruno Gambarotta
Introduzione
LA BOTTEGA DI MARCEL
Spesso facendo un salto nel passato si corre il rischio di andare alla ricerca del tempo perduto. Succede. Forse è inevitabile. Anche se non dovrebbe essere così. Ci si dimentica che l’acqua non passa mai due volte sotto lo stesso ponte. Poi io provo sempre una qualche difficoltà a raccontare ciò che è stato. Non so mai se quanto dico sia stata la verità o ciò che io credo sia stata la verità. Il tempo gioca brutti scherzi alla memoria. A nostra insaputa. Poco importa. L’essenziale è far rivivere ciò che sta dietro alle parole che possono essere più o meno vere. Mi sono fatto carico di scrivere la presentazione di alcune botteghe che rappresentano Torino. La mia città. Lo faccio senza alcuna malinconia.
Il passato, qualunque esso sia, è passato. E chi ha vissuto da bambino gli ultimi anni di guerra non può provare rimpianti per un tempo così duro. I negozi di allora si sono rinnovati. Come le nostre vite. Cambiare è spesso un’esigenza per sopravvivere. Ma a dire il vero questi, che mi va di raccontare, hanno dei frammenti di storia legati alla mia. Forse è per questo che li trovo importanti. Solo ciò che in qualche modo fa parte della nostra esperienza può essere raccontato quando ci si muove tra la storia e la narrazione. Per questo la Torino di cui parlo è quella di oggi ma quasi sempre con riferimenti all’ieri. Le botteghe da me messe in vetrina non sono legate a questioni di mercato (con mercato intendo quello monetario) ma a simpatia gratuita. In ogni caso, comunque la pensiate, ricordatevi di non passare nella bottega di Marcel alla ricerca del tempo perduto.
Il tempo perduto è perduto per sempre.
Mino Rosso